|

"Secolo d'Italia", 31 marzo 2011
Niccolai, Tatarella e il
passato riscritto
Luciano Lanna
Due appuntamenti pubblici che si svolgono quasi
contemporaneamente oggi a Roma mi consentono per una volta di venir meno alla
regola giornalistica di far parlare i fatti e non mettere in primo piano il
proprio vissuto e, sostanzialmente, la propria persona. Mi riferisco, da un
lato, alla presentazione del libro "Una storia di destra" (Longanesi) di Italo
Bocchino, cui partecipano il presidente della Camera, Gianfranco Fini, il
fondatore del PD, Walter Veltroni, e il direttore del "Tg La7", Enrico Mentana;
e dall'altro alla tavola rotonda "Attualità di Beppe Niccolai", che si svolge
sempre questo pomeriggio su iniziativa della Fondazione Rivolta Ideale e che
vede tra i relatori Domenico Gramazio, Maurizio Gasparri, Altero Matteoli,
Gennaro Sangiuliano, Gennaro Malgieri e Adalberto Baldoni.
Si tratta, per dirla tutta, di due occasioni che se lette in parallelo
consentono infatti di mettere la parola fine a qualsiasi tentativo di
ricostruire una genealogia diretta e anche un comune senso d'appartenenza a quel
mondo che per comodità e pigrizia intellettuale viene collocato e, anzi, come
recintato "a destra".
Tutto è davvero cambiato da quando alcune ragioni avevano messo insieme alcune
persone, alcune storie, alcune illusioni. Di quello stare insieme «non c'è più
ragione -ha spiegato il giornalista Filippo Ceccarelli- e in fondo raccontarsi,
classificarsi, insomma venire allo scoperto è anche un po' rompere
l'incantesimo, in qualche modo guarire, forse riscattare antiche colpe fino al
punto di farle comprendere meglio a chi ne ha ancora paura. Perché solo
attraverso una pacata e approfondita autocoscienza sarà possibile riconnettere
la trama della vita civile (e incivile) italiana nella sua interezza, e
consegnarla a chi non l'ha vissuta». Ma per farlo, appunto, è necessario avviare
quell'operazione verità e autenticità che sola consente di restituire senso alle
parole attraverso l'abbandono del tatticismo e di quella che Ezio Mauro ha
chiamato la «invenzione della realtà». In sostanza, potremo entrare davvero in
una nuova fase della vita civile e politica italiana soltanto quando avremo
smesso di "re-inventare il passato" con lo scopo di giustificare le scelte,
spesso banali interessi tattici, del presente.
E veniamo alla presentazione del libro e al tema della tavola rotonda che si
svolgono oggi. Ho letto il saggio dell'amico Bocchino e lo reputo una bella
lettura, coinvolgente, sincera e anche utile per comprendere dall'interno e dal
vissuto il senso e gli sbocchi della transizione politica italiana che s'è
avviata nei primi anni Novanta ed è ancora in corso. E la sua, come sottolinea
lo stesso titolo, è una "storia di destra" che, per quanto si sia incrociata con
la mia -e io "di destra" non mi sono mai considerato, ritenendo la destra, ma
anche la sinistra e, ancor peggio, il centro, categorie topografiche che non
spiegano ormai più niente del mondo del ventunesimo secolo- ha tutte le
caratteristiche di una "storia vera" che non concede nulla alla tentazione
dell'invenzione di comodo. Il solo appunto che gli faccio è quello di riportare
male la vicenda della mia assunzione al "Secolo", che così come riferita -la
fretta, si sa, è spesso origine di errori che però, stampati su un libro,
diventano notizia- non spiega il mio vero inizio al giornalismo. Eravamo nel
giugno del 1990 e io insegnavo lettere nelle scuole. Qualche giorno dopo la fine
dell'anno scolastico, ricevetti una telefonata di Giano Accame, allora direttore
del nostro quotidiano, che mi proponeva tre mesi di lavoro al giornale come
"cambio ferie". Esitai un po', poi accettai perché stare dentro un giornale era
stato sempre il mio sogno. Arrivai in via della Mercede che era il 19 giugno e
lì trovai anche altri quattro "cambi ferie": Italo Bocchino, proposto da
Francesco Storace, Mario Landolfi, suggerito da ambienti della corrente rautiana,
Camillo Scoyni, amico di Gianni Alemanno, e Fabio Andriola, un ragazzo che aveva
già fatto la scuola di giornalismo e conosceva i direttori Aldo Giorleo e Giano
Accame. In seguito seppi che il mio nome era stato suggerito dal mio amico
Umberto Croppi a Domenico Mennitti, il vicesegretario del partito, e che solo
all'ultimo minuto, dopo che erano già stati scelti gli altri, il deputato
brindisino disse: "A questo punto per stare contenti, vorrei proporne uno anche
io". Fatto sta che, dopo tre mesi di lavoro entusiasmante (almeno per me) al
fianco dell'allora capo del politico, Enzo Palmesano, dovendone scegliere uno
solo per l'assunzione, Accame -me lo confidò anni dopo- stretto dalle pressioni
delle correnti volle assumere me, perché ero quello che aveva più passione per
il giornalismo (tanto gli altri opteranno quasi tutti per la politica) e perché
ero quello "meno spinto" e un po' fuori dei giochi...
Se questo è un dettaglio che riporto sorridendo all'amico Italo, il dibattito su
Niccolai rientra invece a tutti gli effetti nella re-invenzione del passato di
cui parlavamo. Come si fa a rivendicare la figura e la lezione di Beppe Niccolai
da parte di chi non solo si considera "di destra" ma che per di più ha aderito
al PDL? Si può anche capire che parlino l'amico Adalberto Baldoni, al quale
Beppe scrisse la prefazione di "Noi rivoluzionari", Gennaro Malgieri, che avendo
studiato a Pisa ebbe modo di conoscerlo e frequentarlo, o Altero Matteoli, che
toscano come lui ne ereditò il seggio alla Camera. Ma Domenico Gramazio,
espressione dell'anticomunismo di piazza e di un antagonismo "senza se e senza
ma" nei confronti della sinistra, oppure Gennaro Sangiuliano, giornalista che è
espressione di una destra liberale, cultore di Giolitti e autore dello scoop
contro Saviano in tv, cosa avrebbero a che vedere con Beppe? Ricordo che, a metà
degli anni '80, durante la presentazione pubblica di una riedizione del libro
"Lo scrittore italiano" di Berto Ricci, Niccolai si trovava a parlare accanto a
Pinuccio Tatarella. E quando i due furono invitati a definirsi rispetto allo
schema destra-sinistra, le due risposte furono profetiche. Non "di destra", ma
"di centrodestra" si definì Tatarella, ricollegandosi legittimamente alla
tradizione politica che negli anni '50 aveva visto molte città del Sud
amministrate da coalizioni composte da MSI, destre liberali e monarchiche e Dc.
Assolutamente "non di destra", anzi "di sinistra", si dichiarò invece Niccolai,
spiegando che sin dal suo rientro dalla prigionia nel 1946 aveva sempre
mantenuto contatti e interlocuzione con suoi amici, come Romano Bilenchi, che
avevano scelto di militare da ex fascisti nel Pci, e che il grande obiettivo
politico all'orizzonte era quello di ricomporre le scissioni socialiste del 1914
e del 1921, rendendo possibile l'ipotesi di mandare la Dc all'opposizione. Come
confermò lo stesso Tatarella in un Comitato centrale del MSI, Niccolai voleva
dar vita a un progetto di «laburismo nazionale», era insomma un autentico uomo
di sinistra e, in prospettiva, sognava la convergenza tra il MSI e la sinistra
italiana.
Ma c'è anche altro. Le conosce Gramazio le posizioni di Niccolai sul '68, sui
diritti degli immigrati, sulla politica estera, sul "caso Sofri"? E come mai la
stragrande maggioranza dei dirigenti politici (e degli amici) che nel 1984 si
schierarono con Beppe -da Umberto Croppi a Peppe Nanni, da Fabio Granata a Enzo
Raisi, da Carmelo Briguglio a Tomaso Staiti- non stanno nel PDL ma hanno fatto
coerentemente altre scelte? Per quanto mi riguarda, vorrei solo ricordare che
sette anni fa ho lasciato un giornale -dove pure ero vicedirettore e lavoravo al
fianco di un amico che stimo intellettualmente come Giordano Bruno Guerri- solo
perché non mi ritrovato nelle posizioni fallaciane sull'Islam e quelle non
garantiste su Sofri che quel foglio aveva assunto. Due punti fermi, due
convinzioni, che mi venivano proprio dalla frequentazione di Beppe. La cui
incompatibilità col PDL è stata ante litteram. D'altronde, nel 2004, l'unico dei
suoi ex oppositori a fare autocritica su Niccolai è stato Gianfranco Fini,
spiegando: «Beppe immaginava già allora di aprirsi al dialogo e sanare da destra
l'equivalente di quella che era stata la scissione a sinistra del 1914 tra
l'anima nazionalista e riformista del socialismo e quella massimalista. Certo,
con lui erano allora in pochi, noi altri in genere ci consolavamo dicendo: siamo
un mondo chiuso. Per la "svolta" era presto...». Ma Niccolai aveva ragione. Al
di là della destra e della sinistra.
Luciano Lanna
Condividi
|
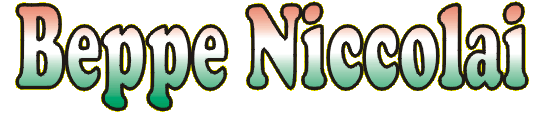
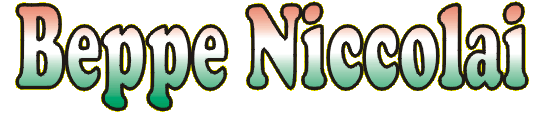
![]()
![]()
![]()