|
La partenza da Genova
«Nelle taverne a Genova ho speso 19,40 lire. Oltre tutto, con
Domingo Fin era combinato il prezzo di 155 lire, esenti da tasse. Ma
quando siamo andati a pagare, ne hanno chiesto 160: tutti ladri.
Siamo arrivati due giorni prima, giusto per farci portar via ancora
un po' di soldi, a Genova, se potessero, ci porterebbero via anche
il cuore (...). Fate in modo di venir via da casa, arrivare a Genova
e partire subito. Prendete quello che serve a Valdagno. Se vi è
possibile, portate una bottiglia di rum, una di olio e delle cipolle
...».
(Paolo Rossato, lettera ai suoi)
Sulla nave
Finalmente, con mille difficoltà, privati dei pochi averi, ci si
imbarcava e si partiva. Più che una nave passeggeri, il bastimento
pareva una nave da carico, piena zeppa di persone «messe a bordo e
ammucchiate come pecore destinate al mattatoio». Toniazzo, nel suo
racconto di viaggio, crede atipica la situazione della nave su cui
si imbarcò per venire in Brasile. Invece, era la regola. La sua
nave, da Genova partì per Napoli e appena attraccò, «il personale si
lanciò a caricare altri 600 napoletani (...) con destinazione Rio de
Janeiro e Buenos Aires. Come eravamo ammucchiati in quella nave, mio
Dio, quando imbarcarono quasi altrettanti passeggeri! In quella
benedetta nave eravamo più di 1.500 persone in terza classe,
schiacciati come sardine in scatola». [...] «I casi di morte erano
frequenti. Sul "Parà" si diffuse un'epidemia che uccise 34 persone.
La nave "Matteo Bruzzo" vagò per tre mesi, affondando cadaveri. Il
naufragio della nave "Sirio", con tutto il suo carico umano, non fu
dimenticato nelle colonie italiane del Rio Grande do Sul. "Sirio,
Sirio, la misera squadra; per moneta gente la misera fin", cantavano
gli immigranti nelle ore di malinconia».
* * *
«Una volta, morirono tutti i bambini di un vapore con 1.800 coloni a
bordo, perchè c'era stata un'epidemia di difterite».
La fazenda
Finalmente arrivavano alla fazenda. Assoggettati a un capo squadra,
spesso schiavo o ex-schiavo, non vedevano quasi mai il padrone, che,
talora, non abitava nemmeno nella fazenda. «L'interno della fazenda
è un piccolo villaggio di reclusi»: una campana chiama al lavoro,
che inizia all'alba e finisce la notte. In molti casi un «pasto che
rivolta lo stomaco più robusto» viene portato per tutti. L'italiano
riceve un tanto per piede di caffè coltivato e un tanto per il caffè
raccolto, ma con questo deve pagare tutti gli acquisti fatti
nell'unico magazzino locale, appartenente al padrone. Alla fine
dell'anno, per quanto si sia fatta economia e si sia lavorato, è ben
poco quello che si riesce ad accumulare.
Il mercato degli schiavi
I fazendeiros paulisti, nello stesso modo e con la stessa mentalità
con cui negli anni precedenti si erano rivolti al mercato degli
schiavi, adesso si rivolgono alla Casa dell'emigrazione per trovare
manodopera per le loro piantagioni. J. Gelain descrisse lo
spettacolo: «Facevano proposte stupende, affermando che i
fazendeiros erano buoni e coscienziosi. Molti italiani credevano
alle bugie degli interpreti e partivano per l'interno. Senza mezzi,
facendo la fame e vivendo in miseria, molte coppie vendevano i loro
pochi averi per non soccombere. Non trovavano neppure case in cui
vivere».
Dopo l'ingaggio, gli immigranti partivano alla volta delle fazendas.
Inizialmente viaggiavano in treno, nelle condizioni più sfavorevoli,
spesso stando in piedi per tutto il viaggio. L'ultimo tratto, poi,
anche cinquanta, settanta e più chilometri, veniva fatto a dorso di
asini da alcuni, a piedi da altri, sotto le intemperie, dormendo
all'aperto.
Farina marcia
Deboli, con poche cure igieniche, senza assistenza medica -la
maggior parte dei dottori erano ciarlatani- male alimentati,
morivano. Uno di loro racconta: «Ricordo che al dazio distribuivano
farina marcia agli immigranti. Fortuna volle, però, che avessimo una
buona stagione di pinoli, perchè diversamente avremmo patito
veramente la fame» (Maestri, 1939). J. Gelain riferisce che un suo
zio, che aveva febbre e mal di testa, impazzì e gridava
disperatamente. La madre ebbe un bimbo e, «in conseguenza del parto,
si ammalò gravemente. Il padre cercò il medico, un certo Napolitano.
Questi sbagliò prescrizione. E la povera madre, fra vomiti e gemiti,
morì 24 ore dopo. Il giorno stesso, morì anche il neonato, di nome
Gaetano. Furono chiusi nella stessa bara».
Lardo pieno di vermi
A. Broetto, narrando le peripezie del colono a Santa Teresa,
Espirito Santo, commenta che, quando qualcuno si ammalava, veniva
portato a spalle a un ospedale, a 13 km di distanza, «attraverso
sentieri dove in Italia non passano nemmeno le capre». «Il cibo che
ci davano era carne di bue salata, chiamata carne secca, ma era
andata a male e puzzava talmente da far venire la nausea, farina di
mais deteriorata, farina di frumento di qualità infima, farina di
manioca (chiamata farinha-de-pau) cruda, acida, baccalà che puzzava
a un chilometro di distanza, lardo pieno di vermi e altri alimenti
di questa qualità».
Dio non volle che io morissi
Nella sua semplicità e nel suo dolore, forse nessuna storia di quei
tempi può essere paragonata a quella raccontata da J. Gelain, in
parte già riportata nelle pagine precedenti. Orfano di madre,
abitava nel Travessao da Barra, vicino al fiume Antas, con il padre
e lo zio; non avevano denaro, non avevano una casa propria e il
raccolto era in ritardo. La zia e un'amica, nella cui casa vivevano,
andavano a chiedere l'elemosina nei dintorni, in casa di coloni
poveri come loro.
«Il giorno in cui si mangiava meglio, il pasto era composto da
polenta con zucchero o pezzettini di zucchero grezzo». Sapendo che
il governo offriva lavoro sulla strada per Paese Novo, dopo Antonio
Prado, andò con lo zio e alcuni suoi amici. Non avevano i soldi,
però, nemmeno per pagare la zattera e così dovettero passare la
notte nel bosco, al freddo e senza cibo. Il giorno dopo il
proprietario della zattera, mosso a pietà, li portò dall'altra parte
del fiume Antas, dove un colono diede loro della canna da zucchero
per placare la fame. A mezzogiorno, finalmente, riuscirono a mettere
nello stomaco polenta senza sale. Dopo 15 giorni di lavoro in
strada, tornarono, pagando persino il proprietario della zattera.
Qualche tempo dopo, sempre in cerca di lavoro, J. Gelain lavorò con
tre compagni alla costruzione della ferrovia Sào Leopoldo-Taquara,
dove rimase cinque mesi. Al ritorno, in pieno inverno, fu trascinato
dalla corrente mentre attraversava il fiume Santa Cruz. Fradicio,
chiese asilo in casa di una famiglia, che glielo rifiutò. «Passammo
la notte in un porcile. Andammo a chiedere dell'acqua calda per dare
sollievo allo stomaco. I cani addentrarono le nostre borse con gli
effetti personali, le aprirono e ci strapparono tutto il caffè,
mentre lo zucchero si era già liquefatto durante l'attraversamento
del fiume. Era una notte di freddo intenso e noi ci trovavamo con
gli abiti bagnati e senza cibo. All'alba del giorno successivo ci fu
una grande gelata. Verso le due del mattino, sentii che le forze mi
mancavano e terrorizzato dissi al mio compagno, Antonio Caon:
«Antonio, quando arriverai a casa, racconta della tragedia che ci è
capitata e soprattutto di' a mio padre che sono morto di fame e di
freddo ..." (...) Il mio compagno soffiò per due ore per darmi un
po' di calore. E Dio non volle che io morissi».
Vengono a popolare i cimiteri
2.300 persone. Vedendo il numero di morti e di disperati un giornale
scrisse: «Ci chiediamo solo se il Brasile chiami gli immigranti per
popolare la terra o i cimiteri».
Meglio in un porcile ma in Italia
Sui coloni di Morretes, nel Paranà, il deputato Antonibon lesse
alcune relazioni al Parlamento italiano del 1880. «Mi trovo qui in
croce, pieno di fame, di sete e tradito. Di cento, ci riducemmo a
quaranta. Chi perse il marito, chi la moglie, chi i figli. Si dice
da queste parti che alcuni del Tirolo si siano mangiati un figlio
(...)». «Siamo come animali: senza prete, senza medico. Non si dà
neppure sepoltura ai morti: siamo peggio di cani incatenati. Di' al
padrone che io sarei più felice nel suo porcile in Italia che in un
palazzo in America». |
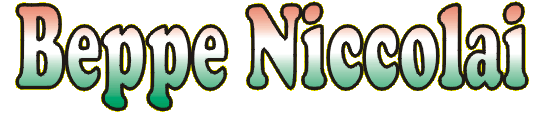
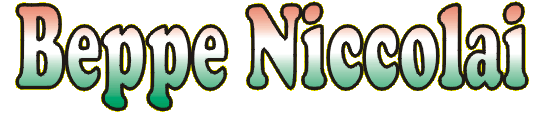
![]()
![]()
![]()