|

da "Plus Ultra", 14 settembre 2010
http://www.plusultraweb.it/?blogid=58/
Uno squarcio su un'altra
destra:
esce "Beppe Niccolai, il
missino, l'eretico"
Luca De Netto
Esiste una destra sconosciuta, una destra per cosi dire "minore", che non ha
avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto, ma che ha
contribuito, in maniera determinante, non solo a gettare le basi dell'attuale
centrodestra, ma a far maturare l'intero panorama politico italiano.
È la destra di Mimmo Mennitti e Beppe Niccolai, di Pino Rauti e Adriano
Romualdi, di Marco Tarchi e Umberto Croppi: destre molto differenti tra loro,
espresse nel corso del tempo da personalità eccezionali, a volte molto scomode,
qualcuna persino inorridita oggi al sol pensiero di essere collocata "a destra",
o ieri di definirsi tale.
Eppure la vulgata ufficiale vuole che i grandi della destra italiana siano stati
Giorgio Almirante e Pinuccio Tatarella, pilastri del Movimento Sociale Italiano
e della sua modernizzazione democratica, ma anche artefici della nascita e
crescita politica di Gianfranco Fini…
La storia che racconta invece Alessandro Amorese nel suo saggio "Beppe Niccolai:
il missino e l'eretico" è una storia differente, non solo perché dedicata ad una
personalità che l'ufficialità mediatica ha voluto considerare "di secondo
piano", ma anche perché apre un varco verso una visione nuova su fatti, eventi e
personaggi relativi ad una Prima Repubblica che ancora ha tanto da dire ed
insegnare.
Giuseppe Niccolai, classe 1920, volontario nella seconda guerra mondiale,
dirigente toscano del MSI, durissimo nei consigli comunali, si scaglia da
deputato soprattutto contro il potere democristiano.
Missino di ferro, vecchio stampo, a volte insopportabile, incarna nella prima
fase della sua vita quel modo di essere tipico della galassia degli uomini di
Almirante: fedelissimi del Capo, intolleranti con qualsiasi movimentismo
autonomo sul territorio, fortemente timorosi di essere superati da qualche
giovane brillante, capace di esprimersi ed in grado di aggregare.
Ma la parabola umana e politica di Niccolai lo porta presto a posizioni
avanguardiste, di rottura, eretiche: sogna di ricucire la frattura con il mondo
social-comunista che si era avuta con la fuoriuscita di Benito Mussolini da
"l'Avanti!", critica Almirante e le posizioni nostalgiche del partito.
Incontra così negli anni '80 Mimmo Mennitti, l'esponente più modernista del MSI,
con cui da vita a riuscitissimi fermenti culturali. I ragazzi del Fronte, sia
pur vicini a Rauti, capo della sinistra interna, simpatizzano fortemente per
questo parlamentare che ricordava tanto Nicolino Bombacci -dirigente di primo
piano del partito comunista che sceglie di morire accanto al Duce in nome
dell'Italia e del Socialismo- e che incantava sognando un'inedita alleanza tra
rossi e neri.
Niccolai intuisce, insieme a Giano Accame e Mimmo Mennitti, che il craxismo
rappresentava una novità politica fondamentale per l'Italia, e si sforza perché
si arrivi ad un dialogo con le componenti socialiste in nome di un nuovo
socialismo tricolore.
Ma un partito appiattito sulle posizioni di retroguardia, incapace di aprirsi
alla cultura -tanto che si era preferito ricorrere all'ex marxista Armando Plebe
per stabilire le politiche culturali missine degli anni '70, invece di guardare
con attenzione ai fermenti che, pur tra mille difficoltà, fiorivano nell'area-,
anziché valorizzare le teste pensanti che dal MSI erano passate, tacciava di
"tradimento" ogni ipotesi di dialogo.
Era eretica, infatti, già l'idea stessa di parlare con chiunque non fosse
missino, figuriamoci il sacrilegio che significava ipotizzare un'alleanza
elettorale con il partito socialista.
Eppure era cosi naturale agli occhi di Niccolai quel percorso in un partito che
avrebbe dovuto rivendicare le proprie radici partendo da una visione del mondo,
e non dal folklore di retroguardia tipico della grigia nomenklatura missina,
contro cui si batte, a viso aperto, il deputato toscano che da vita alla storica
mozione congressuale "segnali di vita".
Sportivo, tagliente, goliardico, ma anche rude, deciso e testardo, non riesce a
vedere la svolta di Rimini del 1990, quando un'inedita alleanza tra Rauti e
Mennitti riesce a battere Fini e portare la sinistra interna alla segreteria,
regalando il sogno -breve e destinato a prendere altre strade del tempo- della
costruzione di qualcosa di nuovo in un partito ormai sclerotizzato: muore
infatti qualche mese prima, lasciando un vuoto politico, ma, come ogni grande,
anche prospettive sul futuro.
Tra gli scritti inediti, infatti, lasciati agli amici, si leggono chiavi di
lettura del presente di una modernità impressionante: la crisi del liberismo
capitalista, la necessità di un nuovo modello socio-economico, il valore della
bellezza al centro del rispetto dell'ambiente, la caduta dei valori autentici a
vantaggio dei falsi bisogni, l'inseminazione artificiale, l'eutanasia,
l'edonismo, le nuovi fonti di energia rinnovabile.
Apparentemente scritti nel terzo millennio, risalgono in realtà all'elaborazione
ideale e politica di un deputato missino negli anni '80. Missino si, ma
fortemente eretico, tanto che il superamento del "missinismo", quel modo di
essere, pensare ed agire così limitato e limitante, potrebbe insegnare tanto
ancora anche ai nostalgici di oggi, molti dei quali quelle vicende non le hanno
neanche vissute.
Un lavoro ottimo, edito da Eclettica, quello di Amorese dunque, ben documentato
e incredibilmente lontano da ogni apologia del personaggio Niccolai.
Una lettura consigliata non solo a destra, ma anche ad una sinistra che, se
vuole tornare a rappresentare qualcosa, necessita di riscoprirsi sociale e
nazionale: solo così la frattura della Patria potrà dirsi ricomposta, e Niccolai
potrà sorridere al suo Paese e al suo Popolo ritrovatosi unito, proprio cosi
come lo aveva sempre sognato.
Luca De Netto |
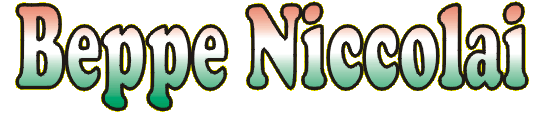
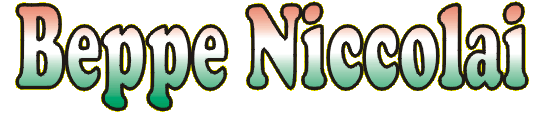
![]()
![]()
![]()